
06 Dic “Sviluppo affettivo e ambiente” di Donald Winnicott
Sviluppo affettivo e ambiente
D.W. Winnicott
Winnicott è uno degli esponenti della scuola psicanalitica che più hanno contribuito alle osservazioni sui bambini, insieme a Melanie Klein e Anna Freud, nei suoi scritti troviamo i prodromi della teoria dell’attaccamento di Bowlby e del costruttivismo di Bruner. Quando parla di bambino Winnicott segnala tre importanti fasi della crescita, su un continuum che va da Dipendenza assoluta a Indipendenza:
1) Dipendenza affettiva assoluta: l’infante é completamente dipendente dalle cure materne e non distingue l’altro da sé da sé
2) Dipendenza affettiva relativa: il bambino “scopre” che la madre non sempre si adatta
alle sue esigenze, e quindi diventa consapevole della sua dipendenza, compare l’ansia legata alla capacità di continuare a credere di poter sopravvivere anche senza di lei. Si sviluppa anche la percezione di esser e una persona senza la madre e di essere una cosa sola.
Se esiste un “non-me, esiste allora anche un “me” il bambino inizia a scoprirsi “agente-nel-mondo” per cui può apportare anche il suo contributo al mondo
3) Verso l’indipendenza: il bambino é capace gradualmente di affrontare il mondo e tutte le sue complessità poiché in esso ritrova ciò che é già presente nel proprio sé.
Nei primi stadi di sviluppo non si può distinguere il sé, questo appare solo quando il bambino agisce e si relaziona nel e col mondo.
Se la madre risponde alle necessità del bambino in modo coerente e continuo, questi può sviluppare un Io forte, quando vengono a mancare queste condizioni nascono delle disfunzionalità dovute ai tentativi di compensare le mancanze (e poi andiamo dal terapeuta da adulti portando questi bambini…). In questa fase il bambino è sempre sul filo che lo separa da uno stato di angoscia fortissima.
Un mancato sostegno, secondo l’autore, può portare a psicosi e schizofrenia.
La madre in questa fase avvolge l’Io del bambino permettendogli di stare al mondo, lo stato e necessariamente fusionale dal momento che da lei dipende l’integrità mentale, emotiva e, non ultimo fisica, del bambino.
Finora ho citato la madre ed il bambino, per Winnicott l’analisi si basa proprio sulla relazione (il trattino) che si instaura in questa diade, ed è sulla relazione che possiamo lavorare.
Secondo l’autore, lo sviluppo sano del bambino dipende dalla qualità dell’ holding che è un’espressione che in italiano si traduce male, letteralmente è tenere, ma in Winnicot credo di poter dire che è una parola carica di molti significati e simboli, con-tenere, tenere nel senso di nutrire (in tutte le sue accezioni espresse sopra).
Particolarmente importante è la funzione della pelle che segna il limite esterno, ma anche interno dell’Io, una sorta di membrana selettivamente permeabile che è la frontiera prima (e ultima) della possibilità di relazionarsi del bambino (e di tutti gli individui). Questa visione di Winnicott mi sembra molto bella perché dà anche un senso biunivoco alla parola limite, ovvero quello di fine ma anche di inizio, che mi sembra anche molto gestaltico.
Alla luce del concetto di limite possiamo continuare con Winnicott quello di differenziazione dalla madre che deve avvenire, perché il bambino possa svilupparsi come entità autonoma, il processo di differenziazione può avvenire solo se vi è una madre “sufficientemente buona” che fornisca al bambino, attraverso un adattamento quasi totale, l’illusione di controllo che lo preserva dall’angoscia che lo ucciderebbe, il catalizzatore di questo controllo è il seno materno. Dal controllo parte una linea di sviluppo sulla quale il bambino, insieme alla madre, impara che non tutto è sotto il suo controllo. Proprio per questo motivo è importante un “seno buono” che accompagni il bambino nella sua esplorazione (qua mi vengono in mente i concetti di “scaffolding” di Bruner e la teoria dell’attaccamento di Bowlby, in entrambi i casi c’è una figura di riferimento che rispettivamente costruisce un impalcatura che poi si ritrae oppure aspetta il bambino in un posto a lui conosciuto permettendogli così di allontanarsi e ritornare )
Le cure genitoriali soddisfacenti possono essere suddivise in tre stadi che si sovrappongono:
a) il sostenere (insieme delle misure ambientali antecedenti al “vivere con”)
b) madre e bambino vivono insieme (il padre funge de mediatore con l’ambiente)
c) padre, madre, figlio vivono tutti insieme (triade)
Durante la fase del sostenere il bambino inizia a diventare una persona a sé.
Attraverso i ricordi delle cure “buone” ricevute il bambino si emancipa e si rende indipendente, una sorta di “fiducia” che funge da oggetto transizionale (metaforico) per rendere tollerabili i vuoti al bambino in crescita.
Uno dei più importanti indici dello sviluppo è quello che riguarda la capacità di stare solo, coerentemente con quanto scritto sopra la solitudine deve essere prima esperita in forma di solitudine con l’altro di riferimento (di nuovo teoria dell’attaccamento), a partire dalle soddisfazioni istintuali esperite in presenza dell’Altro, il bambino può svilupparsi in modo sano.
L’individuo può realizzare lo stadio dell’“io sono” solo perché esiste un ambiente che lo protegge, di fatto costituito dalla madre. Mentre solitamente il bambino è qualcosa in modo reattivo, stando solo con l’Altro, può sperimentare qualcosa di simile al rilassarsi nell’adulto, all0esistere “for his own sake” e non perché non-qualcosa o per reazione. Nel tempo il bambino si costruisce un ambiente interno per cui non è necessaria la presenza fisica della madre.
Un’altra componente fondamentale dello sviluppo affettivo è il senso di colpa, che viene esperito con la madre prima (pulsioni distruttive nei confronti di chi ti da la vita in tutti i sensi) e verso il padre poi (Edipo).
Secondo Winnicott il ciclo sarebbe articolato nelle seguenti fasi:
- esperienza istintuale,
- accettazione della responsabilità (senso di colpa)
- elaborazione
- gesto riparatovi
Se qualcosa non funziona in questo ciclo, non si svilupperebbe la capacità di provare senso di colpa per far posto a diversi meccanismi di difesa.
In quest’ottica il fatto stesso di sviluppare la capacità di odiare ed amare allo stesso tempo lo stesso Oggetto è sinonimo di sanità ed integrità mentale. Dal senso di colpa nasce la capacità di preoccuparsi, la mancanza della quale può portare alla sua sostituzione con angosce e difese primitive, come la scissione o la disintegrazione. Winnicott nel libro porta alcuni casi clinici che esemplificano come nella sua esperienza questo sia stato dimostrato.
Un’altra risultante di un ambiente affettivo inadeguato é lo sviluppo del falso sé, che è espressione di un meccanismo di difesa assai sofisticato e ben radicato nella persona che si identifica a tal punto con questo falso sé, che il vero sé e la spontaneità non emergono mai per lasciare spazio ad una compiacenza che permette alla persona di esistere socialmente.
Spesso si sviluppa un falso sé quando il bambino si trova a dover rispondere a comportamenti ambigui da parte della figura di riferimento primaria.
Torna qua il concetto di esistenza vs quello di reazione, la madre deve identificarsi col bambino e sostenerlo in modo tale che egli possa esistere e non reagire a modificazioni ambientali.
Alla base quindi dell’esistenza di un “vero sé” vi è una cornice ambientale tale da poter offrire al bambino la possibilità e la sicurezza per poter creare e giocare, e quindi anche di aggredire e distruggere, certo della sua sopravvivenza; in mancanza di ciò il bambino sviluppa un’organizzazione dell’Io adattata all’ambiente (compiacenza).
La compiacenza non è il male assoluto, ma può essere anche la manifestazione della capacità di trovare un compromesso tra il vero sé ed il vivere sociale.
OSSERVAZIONI DIRETTE SUL BAMBINO
Attraverso l’osservazione diretta del bambino (che Winnicott chiama infante) è possibile comprendere in che modo entra in relazione con l’oggetto, e che uso ne fa durante il passaggio da una vita puramente soggettiva ad uno stadio successivo di individuazione. E’ possibile osservare tre momenti principali nell’approccio di un infante, di 11 mesi circa, ad un oggetto presentato in una forma prestabilita:
I Fase:
- afferramento riflesso iniziale
- ritiro
- tensione comportante un nuovo afferramento volontario e passaggio lento dell’oggetto alla bocca
II fase
– mette in bocca l’oggetto
– uso libero dell’oggetto nella esplorazione sperimentale , nel gioco come qualcosa che nutre gli altri. a questo punto l’oggetto cade per errore, supponiamo che venga raccolto e restituito al bambino
III fase
– allontanamento
In questo percorso ideale il bambino sviluppa la capacità di essere profondo.
IL PERIODO DI LATENZA
La teoria psicanalitica prevede uno sviluppo continuo dell’Io che avviene attraverso le esperienze del bambino, sempre secondo questa teoria, dai 6 ai 10 anni vi sarebbe un blocco delle pulsioni istintuale, ed un lavoro di elaborazione e preparazione allo stadio successivo. In questo periodo di latenza il bambino:
- è solo, nonostante il bisogno di stare con altri bambini nella sua stessa situazione. I rapporti tra bambini nella fase di latenza possono essere intimi per lunghi periodi, senza diventare sessualizzati in senso manifesto. Questi elementi invece disturbano il gioco nel bambini disturbati in cui il simbolismo “non tiene”.
- è pronto all’introiezione ma non all’incorporazione; può assumere gli elementi completi dalle persone da lui scelte ma non può immergersi in un rapporto intimo che coinvolga l’istinto (mangiare o essere mangiato)
- riesce a manifestare fenomeni interiori senza lasciarsi coinvolgere completamente.
- In questo periodo è l’IO, invece dell’ ID a sostenere la pulsione.
L’ analista impara a scoprire il modello personale della vita emotiva inconscia del paziente che si manifesta col transfert ed è in grado di fornire interpretazioni tali da renderla cosciente al paziente stesso. Nella fase di latenza è difficile fornire interpretazioni, ma, secondo l’autore, è necessario farlo da momento che al paziente quello che importa non è tanto l’accuratezza dell’interpretazione stessa ma la capacità dell’analista di identificarsi con lui e il suo desiderio di aiutarlo, attuando quell’holding di cui parlavamo sopra. Sempre secondo W. È difficile portare avanti un’analisi in questo periodo perché poi si rischia di concluderla nel momento della pubertà, in cui ricompaiono le pulsioni che potrebbero riacutizzare le difese e l’ansia.
L’ADOLESCENZA
Winnicott parla di “bonaccia adolescenziale” per descrivere quegli anni in cui ogni individuo non ha altra scelta che aspettare, senza essere consapevole di ciò che accade. In questa fase il ragazzo non ha un’ identità stabilita e neppure un modo di vita determinato capace di dare una forma al suo futuro, non ha ancora la capacità di identificarsi con le figure genitoriali senza perdere l’identità personale ed è in costante lotta con le sue pulsioni. In questa fase si trovano disturbi di ogni tipo, dalla psiconevrosi ai disturbi affettivi alla psicosi vera e propria, tuttavia in questo stadio è difficile distinguere l’individuo malato da quello sano. Gli adolescenti nella fase della bonaccia usano gli individui malati ai margini del gruppo di appartenenza per dare realtà alla propria sintomatologia potenziale.
APPORTI PSICANALITICI ALLE CLASSIFICAZIONI PSICHIATRICHE
Le malattie mentali sono modelli di compromesso tra successo e insuccesso nello sviluppo affettivo dell’individuo. Così la salute è maturità affettiva, maturità corrispondente all’età, e la malattia mentale ha sempre dietro un blocco dello sviluppo affettivo. In un ambiente favorevole il lattante riesce a sviluppare:
- INTEGRAZIONE. Se non avviene integrazione c’è scissione e questo elemento caratterizza la schizofrenia.
- PERSONALIZZAZIONE. Se non avviene una integrazione tra psiche e corpo si manifestano disturbi psicosomatici o fenomeni di depersonalizzazione.
- RELAZIONE CON L’OGGETTO. Questa capacità è indispensabile all’individuo per sentirsi reale, per tanto non raggiungere questo stadio comporta la perdita di contatto con la realtà e la derealizzazione. Questi sintomi sono alla base della paranoia, della depressione psicotica e dell’ipocondria.
Grazie alla protezione che l’IO della madre offre all’IO del bambino durante lo stato fusionale, questi può avviarsi verso l’individualizzazione e un vita sana, secondo W., quindi, il concetto di regressione non è da riferirsi ad un’età ma alla dipendenza, aprendo in questo modo molti più panorami (mi sembra pacifico che un individuo possa essere dipendente ben oltre le prime fasi della vita). La tendenza regressiva di uno psicotico è il suo tentativo di porre rimedio ai fallimenti ambientali vissuti durante l’infanzia che hanno ostacolato la tendenza naturale dell’individuo a svilupparsi e maturare.
Psiconevrosi è il termine usato per descrivere la malattia degli individui che, nello stadio del complesso edipico, cioè nello stadio dell’esperienza delle relazioni con persone intere, organizzano difese (più o meno rigide a seconda della gravità della malattia) contro l’angoscia di castrazione. Si usa il termine psicosi per indicare che da piccolo l’individuo non è stato in grado di giungere a quel grado di salute che rende significativo il concetto di complesso edipico, dunque l’angoscia di castrazione non ha mai costituito una grave minaccia, mentre le angosce temute sono di disintegrazione, annientamento e di cadere per sempre, che richiedono difese molto più primitive. La differenza sta nel fatto che nel primo caso si parla di oggetto parziale e nel secondo di oggetto intero.
Il falso Sé si costituisce su una base di compiacenza, può avere una funzione difensiva, che è quella di proteggere il vero Sé, che ormai si è strutturato. La psicopatia è una situazione adulta originata da una delinquenza non curata: un delinquente è un ragazzo antisociale non curato che a sua volta è stato un bambino deprivato, in un’epoca in cui era sufficientemente organizzato da subire come traumatica la deprivazione. Secondo l’autore quando, invece, si verificano ripetuti fallimenti ambientali in uno stadio in cui il bambino non possiede ancora gli strumenti per prenderne consapevolezza, allora si determina la psicosi.
DIFFERENZE NELLA TECNICA PSICANALITICA
Winnicott ci dà delle indicazioni di comportamento sulla condotta da tenersi con pazienti che presentano varie psicopatologie:
Con lo psiconevrotico l’analista deve interpretare l’amore e l’odio come appaiono nelle nevrosi da transfert, e questo significa riportare all’infanzia ciò che sta succedendo. Questo ha a che fare con il modo che il paziente ha di rapportarsi con gli oggetti.
Con il paziente depresso l’analista deve sopravvivere all’aggressività che accompagna l’amore. La depressione reattiva somiglia alla nevrosi e richiede l’interpretazione del transfert. Ma la depressione ha bisogno che l’analista sopravviva in quanto ciò dà al paziente il tempo di riunire gli elementi nella propria realtà interiore affinché anche l’analista interiore possa sopravvivere. Anche la depressione implica una forza dell’io e per tanto la capacità dell’individuo di far fronte al senso di colpa e all’ambivalenza.
Nel trattamento con gli schizoidi l’analista ha bisogno di comprendere tutti gli aspetti del materiale presentato, ma anche di sapersi astenere dal tradurre in interpretazioni questa comprensione. Infatti il paziente ha soprattutto bisogno di un supporto dell’io o di un sostegno generico. L’holding, come il compito della madre nell’assistere l’infante, riconosce l’ angoscia del paziente a disgregarsi, a cessare di esistere, a cadere per sempre.
DISTORSIONE DELL’IO IN RAPPORTO AL VERO E AL FALSO SÈ
L’organizzazione del falso sé nel proteggere il vero sé si articola lungo un continuum:
- Polo estremo: il Falso Sé si costituisce come reale e chi osserva tende a prenderlo per la persona reale, componente manipolativa alta
- Livello meno grave: il vero Sé è riconosciuto come potenziale e gli viene riconosciuta una vita segreta (l’individuo è in contatto, ma non ce la fa)
- Il falso Sé ha come obiettivo la ricerca di situazioni tali da permettere al vero Sé di emergere in condizioni di sicurezza.
- Livello più vicino alla salute: il Falso sé si forma sulla base di identificazioni
- Salute: il Falso Sé è rappresentato da un atteggiamento sociale che permette all’individuo di avere un posto nella società (compromesso sano)
La madre non sufficientemente buona sostituisce le proprie istanze a quelle del figlio, soffocandole, per cui il bambino si trova a dover essere compiacente, pena la morte. Questa compiacenza è lo stadio primario precoce del Falso Sé.
IL CONTROTRANSFERT
Assumendo che la cosa fondamentale nella terapia (e l’analisi non fa eccezione) sia la relazione, il trattino, l’analista (il terapeuta) ha un ruolo nel setting terapeutico che gli permette di essere curativo per il paziente. La relazione terapeutica implica anche una distanza con il paziente che permetta al terapeuta di non entrare in un incastro mortifero col paziente. Secondo Winnicott questo è vero ma con delle eccezioni, in quanto, il ruolo dell’analista deve variare rispetto alla diagnosi del paziente:
- Il paziente con una tendenza antisociale avrà bisogno che il terapeuta continui a correggere la condizione di mancanza di sostegno dell’IO che ha modificato il corso della vita del paziente stesso. L’unica cosa che il terapeuta può fare, a parte l’essere coinvolto, è di utilizzare ciò che accade nel tentativo di approdare ad una precisa identificazione della originaria deprivazione percepita dal paziente quando era bambino, questo non necessariamente implica un lavoro con l’inconscio del paziente.
- Il paziente psicotico o borderline avrà bisogno di una regressione alla fase di dipendenza infantile. Smontare il Falso Sé, per permettere al vero Sé immaturo di venire alla luce, provocherà un crollo del paziente e allora il terapeuta dovrà essere in grado di sostenere la parte della madre per il bambino che c’è in lui, offrendo un massiccio sostegno all’IO. L’analista dovrà rimanere orientato alla realtà esterna mentre di fatto è identificato col paziente, perfino in simbiosi con lui, che diverrà totalmente dipendente.
I FINI DEL TRATTAMENTO PSICOANALITICO
Il fine della psicoanalisi classica è quello di verbalizzare il conscio nascente in termini di transfert. Fornire delle interpretazioni, per l’autore è utile per due motivi:
- fare interpretazioni imprecise o errate consente all’analista (che non capisce tutto del paziente) di conservare la natura di oggetto esterno.
- la verbalizzazione, al momento giusto, mobilita le forze intellettuali, cosa positiva se queste non sono dissociate dall’essere psicosomatico, e questo rafforza l’Io del paziente e il suo diritto di esistere.
>Winnicott inoltre fa un passaggio importantissimo rispetto alla rigidità della psicanalisi, riferendosi alle interpretazioni. “Possiamo fare interpretazioni in modo che può essere chiamato sempre più profondo ma così facendo ci allontaniamo dalla situazione di bambino che c’è nel paziente, perché un bambino è una bambino da assistere.”
In qualche modo ci rimanda a Naranjo quando asserisce che i professionisti con una certa esperienza si assomiglino tutti nonostante possano avere una formazione diversa.[:en]Sviluppo affettivo e ambiente
D.W. Winnicott
Winnicott è uno degli esponenti della scuola psicanalitica che più hanno contribuito alle osservazioni sui bambini, insieme a Melanie Klein e Anna Freud, nei suoi scritti troviamo i prodromi della teoria dell’attaccamento di Bowlby e del costruttivismo di Bruner. Quando parla di bambino Winnicott segnala tre importanti fasi della crescita, su un continuum che va da Dipendenza assoluta a Indipendenza:
1) Dipendenza assoluta: l’infante é completamente dipendente dalle cure materne e non distingue l’altro da sé da sé
2) Dipendenza relativa: il bambino “scopre” che la madre non sempre si adatta alle sue esigenze, e quindi diventa consapevole della sua dipendenza, compare l’ansia legata alla capacità di continuare a credere di poter sopravvivere anche senza di lei. Si sviluppa anche la percezione di esser e una persona senza la madre e di essere una cosa sola.
Se esiste un “non-me, esiste allora anche un “me” il bambino inizia a scoprirsi “agente-nel-mondo” per cui può apportare anche il suo contributo al mondo
3) Verso l’indipendenza: il bambino é capace gradualmente di affrontare il mondo e tutte le sue complessità poiché in esso ritrova ciò che é già presente nel proprio sé.
Nei primi stadi di sviluppo non si può distinguere il sé, questo appare solo quando il bambino agisce e si relaziona nel e col mondo.
Se la madre risponde alle necessità del bambino in modo coerente e continuo, questi può sviluppare un Io forte, quando vengono a mancare queste condizioni nascono delle disfunzionalità dovute ai tentativi di compensare le mancanze (e poi andiamo dal terapeuta da adulti portando questi bambini…). In questa fase il bambino è sempre sul filo che lo separa da uno stato di angoscia fortissima.
Un mancato sostegno, secondo l’autore, può portare a psicosi e schizofrenia.
La madre in questa fase avvolge l’Io del bambino permettendogli di stare al mondo, lo stato e necessariamente fusionale dal momento che da lei dipende l’integrità mentale, emotiva e, non ultimo fisica, del bambino.
Finora ho citato la madre ed il bambino, per Winnicott l’analisi si basa proprio sulla relazione (il trattino) che si instaura in questa diade, ed è sulla relazione che possiamo lavorare.
Secondo l’autore, lo sviluppo sano del bambino dipende dalla qualità dell’ holding che è un’espressione che in italiano si traduce male, letteralmente è tenere, ma in Winnicot credo di poter dire che è una parola carica di molti significati e simboli, con-tenere, tenere nel senso di nutrire (in tutte le sue accezioni espresse sopra).
Particolarmente importante è la funzione della pelle che segna il limite esterno, ma anche interno dell’Io, una sorta di membrana selettivamente permeabile che è la frontiera prima (e ultima) della possibilità di relazionarsi del bambino (e di tutti gli individui). Questa visione di Winnicott mi sembra molto bella perché dà anche un senso biunivoco alla parola limite, ovvero quello di fine ma anche di inizio, che mi sembra anche molto gestaltico.
Alla luce del concetto di limite possiamo continuare con Winnicott quello di differenziazione dalla madre che deve avvenire, perché il bambino possa svilupparsi come entità autonoma, il processo di differenziazione può avvenire solo se vi è una madre “sufficientemente buona” che fornisca al bambino, attraverso un adattamento quasi totale, l’illusione di controllo che lo preserva dall’angoscia che lo ucciderebbe, il catalizzatore di questo controllo è il seno materno. Dal controllo parte una linea di sviluppo sulla quale il bambino, insieme alla madre, impara che non tutto è sotto il suo controllo. Proprio per questo motivo è importante un “seno buono” che accompagni il bambino nella sua esplorazione (qua mi vengono in mente i concetti di “scaffolding” di Bruner e la teoria dell’attaccamento di Bowlby, in entrambi i casi c’è una figura di riferimento che rispettivamente costruisce un impalcatura che poi si ritrae oppure aspetta il bambino in un posto a lui conosciuto permettendogli così di allontanarsi e ritornare )
Le cure genitoriali soddisfacenti possono essere suddivise in tre stadi che si sovrappongono:
a) il sostenere (insieme delle misure ambientali antecedenti al “vivere con”)
b) madre e bambino vivono insieme (il padre funge de mediatore con l’ambiente)
c) padre, madre, figlio vivono tutti insieme (triade)
Durante la fase del sostenere il bambino inizia a diventare una persona a sé.
Attraverso i ricordi delle cure “buone” ricevute il bambino si emancipa e si rende indipendente, una sorta di “fiducia” che funge da oggetto transizionale (metaforico) per rendere tollerabili i vuoti al bambino in crescita.
Uno dei più importanti indici dello sviluppo è quello che riguarda la capacità di stare solo, coerentemente con quanto scritto sopra la solitudine deve essere prima esperita in forma di solitudine con l’altro di riferimento (di nuovo teoria dell’attaccamento), a partire dalle soddisfazioni istintuali esperite in presenza dell’Altro, il bambino può svilupparsi in modo sano.
L’individuo può realizzare lo stadio dell’“io sono” solo perché esiste un ambiente che lo protegge, di fatto costituito dalla madre. Mentre solitamente il bambino è qualcosa in modo reattivo, stando solo con l’Altro, può sperimentare qualcosa di simile al rilassarsi nell’adulto, all0esistere “for his own sake” e non perché non-qualcosa o per reazione. Nel tempo il bambino si costruisce un ambiente interno per cui non è necessaria la presenza fisica della madre.
Un’altra componente fondamentale dello sviluppo affettivo è il senso di colpa, che viene esperito con la madre prima (pulsioni distruttive nei confronti di chi ti da la vita in tutti i sensi) e verso il padre poi (Edipo).
Secondo Winnicott il ciclo sarebbe articolato nelle seguenti fasi:
- esperienza istintuale,
- accettazione della responsabilità (senso di colpa)
- elaborazione
- gesto riparatovi
Se qualcosa non funziona in questo ciclo, non si svilupperebbe la capacità di provare senso di colpa per far posto a diversi meccanismi di difesa.
In quest’ottica il fatto stesso di sviluppare la capacità di odiare ed amare allo stesso tempo lo stesso Oggetto è sinonimo di sanità ed integrità mentale. Dal senso di colpa nasce la capacità di preoccuparsi, la mancanza della quale può portare alla sua sostituzione con angosce e difese primitive, come la scissione o la disintegrazione. Winnicott nel libro porta alcuni casi clinici che esemplificano come nella sua esperienza questo sia stato dimostrato.
Un’altra risultante di un ambiente affettivo inadeguato é lo sviluppo del falso sé, che è espressione di un meccanismo di difesa assai sofisticato e ben radicato nella persona che si identifica a tal punto con questo falso sé, che il vero sé e la spontaneità non emergono mai per lasciare spazio ad una compiacenza che permette alla persona di esistere socialmente.
Spesso si sviluppa un falso sé quando il bambino si trova a dover rispondere a comportamenti ambigui da parte della figura di riferimento primaria.
Torna qua il concetto di esistenza vs quello di reazione, la madre deve identificarsi col bambino e sostenerlo in modo tale che egli possa esistere e non reagire a modificazioni ambientali.
Alla base quindi dell’esistenza di un “vero sé” vi è una cornice ambientale tale da poter offrire al bambino la possibilità e la sicurezza per poter creare e giocare, e quindi anche di aggredire e distruggere, certo della sua sopravvivenza; in mancanza di ciò il bambino sviluppa un’organizzazione dell’Io adattata all’ambiente (compiacenza).
La compiacenza non è il male assoluto, ma può essere anche la manifestazione della capacità di trovare un compromesso tra il vero sé ed il vivere sociale.
OSSERVAZIONI DIRETTE SUL BAMBINO
Attraverso l’osservazione diretta del bambino (che Winnicott chiama infante) è possibile comprendere in che modo entra in relazione con l’oggetto, e che uso ne fa durante il passaggio da una vita puramente soggettiva ad uno stadio successivo di individuazione. E’ possibile osservare tre momenti principali nell’approccio di un infante, di 11 mesi circa, ad un oggetto presentato in una forma prestabilita:
I Fase:
- afferramento riflesso iniziale
- ritiro
- tensione comportante un nuovo afferramento volontario e passaggio lento dell’oggetto alla bocca
II fase
– mette in bocca l’oggetto
– uso libero dell’oggetto nella esplorazione sperimentale , nel gioco come qualcosa che nutre gli altri. a questo punto l’oggetto cade per errore, supponiamo che venga raccolto e restituito al bambino
III fase
– allontanamento
In questo percorso ideale il bambino sviluppa la capacità di essere profondo.
IL PERIODO DI LATENZA
La teoria psicanalitica prevede uno sviluppo continuo dell’Io che avviene attraverso le esperienze del bambino, sempre secondo questa teoria, dai 6 ai 10 anni vi sarebbe un blocco delle pulsioni istintuale, ed un lavoro di elaborazione e preparazione allo stadio successivo. In questo periodo di latenza il bambino:
- è solo, nonostante il bisogno di stare con altri bambini nella sua stessa situazione. I rapporti tra bambini nella fase di latenza possono essere intimi per lunghi periodi, senza diventare sessualizzati in senso manifesto. Questi elementi invece disturbano il gioco nel bambini disturbati in cui il simbolismo “non tiene”.
- è pronto all’introiezione ma non all’incorporazione; può assumere gli elementi completi dalle persone da lui scelte ma non può immergersi in un rapporto intimo che coinvolga l’istinto (mangiare o essere mangiato)
- riesce a manifestare fenomeni interiori senza lasciarsi coinvolgere completamente.
- In questo periodo è l’IO, invece dell’ ID a sostenere la pulsione.
L’ analista impara a scoprire il modello personale della vita emotiva inconscia del paziente che si manifesta col transfert ed è in grado di fornire interpretazioni tali da renderla cosciente al paziente stesso. Nella fase di latenza è difficile fornire interpretazioni, ma, secondo l’autore, è necessario farlo da momento che al paziente quello che importa non è tanto l’accuratezza dell’interpretazione stessa ma la capacità dell’analista di identificarsi con lui e il suo desiderio di aiutarlo, attuando quell’holding di cui parlavamo sopra. Sempre secondo W. È difficile portare avanti un’analisi in questo periodo perché poi si rischia di concluderla nel momento della pubertà, in cui ricompaiono le pulsioni che potrebbero riacutizzare le difese e l’ansia.
L’ADOLESCENZA
Winnicott parla di “bonaccia adolescenziale” per descrivere quegli anni in cui ogni individuo non ha altra scelta che aspettare, senza essere consapevole di ciò che accade. In questa fase il ragazzo non ha un’ identità stabilita e neppure un modo di vita determinato capace di dare una forma al suo futuro, non ha ancora la capacità di identificarsi con le figure genitoriali senza perdere l’identità personale ed è in costante lotta con le sue pulsioni. In questa fase si trovano disturbi di ogni tipo, dalla psiconevrosi ai disturbi affettivi alla psicosi vera e propria, tuttavia in questo stadio è difficile distinguere l’individuo malato da quello sano. Gli adolescenti nella fase della bonaccia usano gli individui malati ai margini del gruppo di appartenenza per dare realtà alla propria sintomatologia potenziale.
APPORTI PSICANALITICI ALLE CLASSIFICAZIONI PSICHIATRICHE
Le malattie mentali sono modelli di compromesso tra successo e insuccesso nello sviluppo affettivo dell’individuo. Così la salute è maturità affettiva, maturità corrispondente all’età, e la malattia mentale ha sempre dietro un blocco dello sviluppo affettivo. In un ambiente favorevole il lattante riesce a sviluppare:
- INTEGRAZIONE. Se non avviene integrazione c’è scissione e questo elemento caratterizza la schizofrenia.
- PERSONALIZZAZIONE. Se non avviene una integrazione tra psiche e corpo si manifestano disturbi psicosomatici o fenomeni di depersonalizzazione.
- RELAZIONE CON L’OGGETTO. Questa capacità è indispensabile all’individuo per sentirsi reale, per tanto non raggiungere questo stadio comporta la perdita di contatto con la realtà e la derealizzazione. Questi sintomi sono alla base della paranoia, della depressione psicotica e dell’ipocondria.
Grazie alla protezione che l’IO della madre offre all’IO del bambino durante lo stato fusionale, questi può avviarsi verso l’individualizzazione e un vita sana, secondo W., quindi, il concetto di regressione non è da riferirsi ad un’età ma alla dipendenza, aprendo in questo modo molti più panorami (mi sembra pacifico che un individuo possa essere dipendente ben oltre le prime fasi della vita). La tendenza regressiva di uno psicotico è il suo tentativo di porre rimedio ai fallimenti ambientali vissuti durante l’infanzia che hanno ostacolato la tendenza naturale dell’individuo a svilupparsi e maturare.
Psiconevrosi è il termine usato per descrivere la malattia degli individui che, nello stadio del complesso edipico, cioè nello stadio dell’esperienza delle relazioni con persone intere, organizzano difese (più o meno rigide a seconda della gravità della malattia) contro l’angoscia di castrazione. Si usa il termine psicosi per indicare che da piccolo l’individuo non è stato in grado di giungere a quel grado di salute che rende significativo il concetto di complesso edipico, dunque l’angoscia di castrazione non ha mai costituito una grave minaccia, mentre le angosce temute sono di disintegrazione, annientamento e di cadere per sempre, che richiedono difese molto più primitive. La differenza sta nel fatto che nel primo caso si parla di oggetto parziale e nel secondo di oggetto intero.
Il falso Sé si costituisce su una base di compiacenza, può avere una funzione difensiva, che è quella di proteggere il vero Sé, che ormai si è strutturato. La psicopatia è una situazione adulta originata da una delinquenza non curata: un delinquente è un ragazzo antisociale non curato che a sua volta è stato un bambino deprivato, in un’epoca in cui era sufficientemente organizzato da subire come traumatica la deprivazione. Secondo l’autore quando, invece, si verificano ripetuti fallimenti ambientali in uno stadio in cui il bambino non possiede ancora gli strumenti per prenderne consapevolezza, allora si determina la psicosi.
DIFFERENZE NELLA TECNICA PSICANALITICA
Winnicott ci dà delle indicazioni di comportamento sulla condotta da tenersi con pazienti che presentano varie psicopatologie:
Con lo psiconevrotico l’analista deve interpretare l’amore e l’odio come appaiono nelle nevrosi da transfert, e questo significa riportare all’infanzia ciò che sta succedendo. Questo ha a che fare con il modo che il paziente ha di rapportarsi con gli oggetti.
Con il paziente depresso l’analista deve sopravvivere all’aggressività che accompagna l’amore. La depressione reattiva somiglia alla nevrosi e richiede l’interpretazione del transfert. Ma la depressione ha bisogno che l’analista sopravviva in quanto ciò dà al paziente il tempo di riunire gli elementi nella propria realtà interiore affinché anche l’analista interiore possa sopravvivere. Anche la depressione implica una forza dell’io e per tanto la capacità dell’individuo di far fronte al senso di colpa e all’ambivalenza.
Nel trattamento con gli schizoidi l’analista ha bisogno di comprendere tutti gli aspetti del materiale presentato, ma anche di sapersi astenere dal tradurre in interpretazioni questa comprensione. Infatti il paziente ha soprattutto bisogno di un supporto dell’io o di un sostegno generico. L’holding, come il compito della madre nell’assistere l’infante, riconosce l’ angoscia del paziente a disgregarsi, a cessare di esistere, a cadere per sempre.
DISTORSIONE DELL’IO IN RAPPORTO AL VERO E AL FALSO SÈ
L’organizzazione del falso sé nel proteggere il vero sé si articola lungo un continuum:
- Polo estremo: il Falso Sé si costituisce come reale e chi osserva tende a prenderlo per la persona reale, componente manipolativa alta
- Livello meno grave: il vero Sé è riconosciuto come potenziale e gli viene riconosciuta una vita segreta (l’individuo è in contatto, ma non ce la fa)
- Il falso Sé ha come obiettivo la ricerca di situazioni tali da permettere al vero Sé di emergere in condizioni di sicurezza.
- Livello più vicino alla salute: il Falso sé si forma sulla base di identificazioni
- Salute: il Falso Sé è rappresentato da un atteggiamento sociale che permette all’individuo di avere un posto nella società (compromesso sano)
La madre non sufficientemente buona sostituisce le proprie istanze a quelle del figlio, soffocandole, per cui il bambino si trova a dover essere compiacente, pena la morte. Questa compiacenza è lo stadio primario precoce del Falso Sé.
IL CONTROTRANSFERT
Assumendo che la cosa fondamentale nella terapia (e l’analisi non fa eccezione) sia la relazione, il trattino, l’analista (il terapeuta) ha un ruolo nel setting terapeutico che gli permette di essere curativo per il paziente. La relazione terapeutica implica anche una distanza con il paziente che permetta al terapeuta di non entrare in un incastro mortifero col paziente. Secondo Winnicott questo è vero ma con delle eccezioni, in quanto, il ruolo dell’analista deve variare rispetto alla diagnosi del paziente:
- Il paziente con una tendenza antisociale avrà bisogno che il terapeuta continui a correggere la condizione di mancanza di sostegno dell’IO che ha modificato il corso della vita del paziente stesso. L’unica cosa che il terapeuta può fare, a parte l’essere coinvolto, è di utilizzare ciò che accade nel tentativo di approdare ad una precisa identificazione della originaria deprivazione percepita dal paziente quando era bambino, questo non necessariamente implica un lavoro con l’inconscio del paziente.
- Il paziente psicotico o borderline avrà bisogno di una regressione alla fase di dipendenza infantile. Smontare il Falso Sé, per permettere al vero Sé immaturo di venire alla luce, provocherà un crollo del paziente e allora il terapeuta dovrà essere in grado di sostenere la parte della madre per il bambino che c’è in lui, offrendo un massiccio sostegno all’IO. L’analista dovrà rimanere orientato alla realtà esterna mentre di fatto è identificato col paziente, perfino in simbiosi con lui, che diverrà totalmente dipendente.
I FINI DEL TRATTAMENTO PSICOANALITICO
Il fine della psicoanalisi classica è quello di verbalizzare il conscio nascente in termini di transfert. Fornire delle interpretazioni, per l’autore è utile per due motivi:
- fare interpretazioni imprecise o errate consente all’analista (che non capisce tutto del paziente) di conservare la natura di oggetto esterno.
- la verbalizzazione, al momento giusto, mobilita le forze intellettuali, cosa positiva se queste non sono dissociate dall’essere psicosomatico, e questo rafforza l’Io del paziente e il suo diritto di esistere.
Winnicott inoltre fa un passaggio importantissimo rispetto alla rigidità della psicanalisi, riferendosi alle interpretazioni. “Possiamo fare interpretazioni in modo che può essere chiamato sempre più profondo ma così facendo ci allontaniamo dalla situazione di bambino che c’è nel paziente, perché un bambino è una bambino da assistere.”
In qualche modo ci rimanda a Naranjo quando asserisce che i professionisti con una certa esperienza si assomiglino tutti nonostante possano avere una formazione diversa.
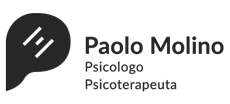

Sorry, the comment form is closed at this time.